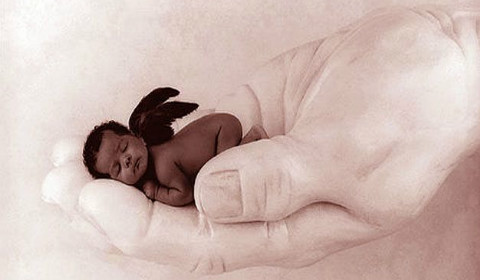Questo articolo riprende il filo del convegno organizzato da CIAI, di cui si è già parlato nell’articolo “Adottivi non si nasce, si diventa”, in cui i figli hanno preso la parola ed hanno portato il loro contributo ad un vasto pubblico. Tra i tanti temi affrontati, si è parlato di identità etnica e ritorno alle origini. La ricerca è un bisogno di tutti, ma non è vissuta da tutti allo stesso modo; c’è chi parla di curiosità, chi di paura, di timore e di serenità.
In tutto questo, i genitori adottivi hanno un ruolo fondamentale poiché attraverso il loro atteggiamento possono condizionare la ricerca; ci sono genitori che hanno accompagnato il proprio figlio, o che comunque hanno appoggiato questa sua volontà, altri che invece hanno vissuto il tutto con un pizzico di spavento che talvolta può sfociare in un sentimento di tradimento. Il dialogo e la trasparenza in famiglia consentono un clima di maggior serenità, portando a fare meno domande. Invece, è quando le informazioni vengono negate, che ci si accanisce maggiormente. È importante sottolineare che cercare non significa tradire l’amore: “la ricerca è un diritto che va oltre l’amore”. La questione etnica si lega al rapporto con le origini; “Se hai la pelle scura o gli occhi a mandorla, si può essere un vero italiano?”
A prescindere dall’età di arrivo in Italia si deve affrontare la doppia cultura; “Non c’è omogeneità se sentirsi o meno italiani”. A tal proposito V.A. ha detto: “Sono italiano, mangio italiano, non so parlare l’hindi ma io sono nato là!”
Il razzismo è presente, all’interno della nostra società ed il giovane ha continuato affermando: “Io ho vissuto il razzismo, l’ho accettato e ci ho fatto i conti, ho dovuto fare pace con quello che sono: Indiano”.
Se si possiedono caratteristiche somatiche differenti da quelle europee, allora si presenta la possibilità di essere ‘etichettato’ e ogni giorno la quotidianità ti mette di fronte al dover raccontare sempre la propria storia. V.A ha ribadito: “Noi siamo italiani di colore”.
Del meeting di Bologna essi riportano un senso di fratellanza; non era importante se eri bianco, giallo, marrone con gli occhi a mandorla o scuri, l’importante era essere là assieme per capirsi: “C’era posto per ognuno di noi”.
Come riportato da Katia M., molti sono gli adulti adottati che considerano la doppia cultura una fortuna; alle volte, invece, alcuni tasselli del proprio puzzle mancano, tanto da non sentirsi italiani al 100% e questo comporta una ricerca continua per formare i proprio sé. Tutti hanno evidenziato la fatica del ‘dover spiegare’ il proprio status di italiani perché talvolta la paura del ‘diverso’ esiste eccome. Esiste un ‘razzismo latente’ per cui come riportato da V.A: “Alcune volte le persone trattengono verso di sé la borsa, come per paura che io, solo perché di colore, possa essere uno scippatore”.
La doppia identità dovrebbe essere una ricchezza da cogliere, come quando si impara una lingua straniera senza cancellare la propria. Talvolta nel periodo adolescenziale può nascere un conflitto ulteriore, poiché il desiderio di piena omologazione può scontrarsi con ‘l’essere somaticamente diversi’. Al contrario, questa diversità, in relazione ai genitori, mette il giovane a doversi continuamente ‘spiegare’ e ciò porta alla formazione di un carattere forte. Dobbiamo renderci conto tutti che le differenze somatiche, etniche e culturali non sono un disvalore sociale, bensì un arricchimento per tutti noi.
Se si parla di ritorno alle origini, è importante dare voce anche a tutti coloro che, seppur non hanno tratti somatici differenti hanno la necessità di conoscere e di sapere. All’interno del panorama nazionale, si schierano due visioni differenti; durante il convegno sono emersi i pareri di due figli adulti che hanno una visione differente rispetto alla conoscenza delle proprie origini biologiche. Vi è stata una doppia intervista, condotta dal dott. Chistolini, a John Campitelli (FAEGN) e Federico Milazzo (ANFAA). Per entrambi vi è stata una breve presentazione della propria storia e del vissuto come figlio adottivo. Il rappresentante dell’ANFAA ha ribadito il fatto di sentirsi a tutti gli effetti un figlio di ‘serie A’ nonostante la presenza in famiglia di altri figli biologici. Ha precisato che talvolta, la chiusura dei ragazzi nel narrare la propria storia deriva da un tabù presente in famiglia.
L’esperienza di Campitelli – adottato da genitori americani – che ha avuto la possibilità di ritrovare i genitori biologici, ha rimarcato l’orgoglio di essere adottivo, caratteristica che va considerata un valore aggiunto nella propria vita. L’Italia, riportando proprio la sua esperienza, sembra essere solo oggi ad una ‘maturità iniziale’ di dialogo, cosa che in America si ha già da molto tempo.
Alla domanda del dott. Chistolini: “Voi siete uguali ai figli biologici?” Milazzo ha risposto: “In casa si è sempre parlato quotidianamente di adozione; non si è mai fatto differenza tra me e i miei fratelli, mi hanno sempre rispettato per quello che sono attraverso le mie specificità e le mie doti!”
Campitelli ha risposto: “Io, innanzitutto, sono una persona, un figlio, un marito, un padre, in più ho il valore dell’adozione”
Fino a questo punto il dibattito è stato lineare, per poi trasformarsi e prendere un ‘tono più acceso’ proprio sulla questione “ritorno alle origini” poiché tra Milazzo e Campitelli, vi sono due posizioni inconciliabili.
“Conoscere le proprie origini… Perché saperlo?” (Ripresa istanza del Tribunale di Catanzaro il quale ha sostenuto che senza un’identità biologica non si possa giungere in definitiva ad un’identità concreta, cosa che accade oggi ai figli non riconosciuti alla nascita).
Per approfondire è possibile visionare l’articolo e la sentenza, inerente la pronuncia della Corte costituzionale, nel novembre 2013.
John Campitelli ha ribadito, durante la discussione, il ‘diritto’ per ciascun figlio adottivo di conoscere le proprie origini. Questo diritto che è presente già a partire dal 2001 per i figli riconosciuti alla nascita, dovrebbe essere esteso a tutti attraverso la modifica della legge. Riportando la sua esperienza, egli ha aggiunto: “Aver avuto la possibilità di guardare negli occhi, di confrontarmi con il mio passato, è stato importante per il mio patrimonio storico”.
Milazzo, il quale non ha cercato le proprie origini, ha dibattuto sostenendo: “Non nego il diritto a chi vuole sapere, ma, allora non chiamiamoci adottivi”; “Io non ho questa necessità perché i miei genitori hanno colmato tutte le mie lacune”. Egli stesso in un’intervista a TV2000 (dicembre 2012) ha sostenuto: “Se un ragazzo adottato arrivato ad una certa età sente la necessità di ricercare i propri genitori biologici, credo che questo possa venire perché nella crescita nella famiglia adottiva i genitori non hanno colmato tutte le sue lacune materiali, psicologiche ed affettive”.
Dare questo ‘diritto’ secondo Milazzo, significa confondere il concetto di famiglia.
In sintesi, le ricerche condotte in questi anni, mostrano che: gran parte dei figli adottivi cerca informazioni relative al proprio passato e lo fa a partire da una riuscita dell’adozione. Ciò contrasta l’idea che i genitori adottivi siano, in questo caso, cattivi genitori. Ad ogni modo, se facciamo un confronto tra chi cerca e chi non lo fa, sembra che quest’ultimi vivano un maggior benessere.
E’ difficile prendere una posizione rispetto questa delicata tematica; ciascuno nella vita vive esperienze differenti, l’importante è che il ritorno alle origini, mentale o fisico che sia, possa portare alla costruzione di un’identità propria e serena. È bene ricordarsi che: “Anche se la vita è incominciata male (passato), è importante ciò che siamo (presente) e ciò che decidiamo di essere (futuro).